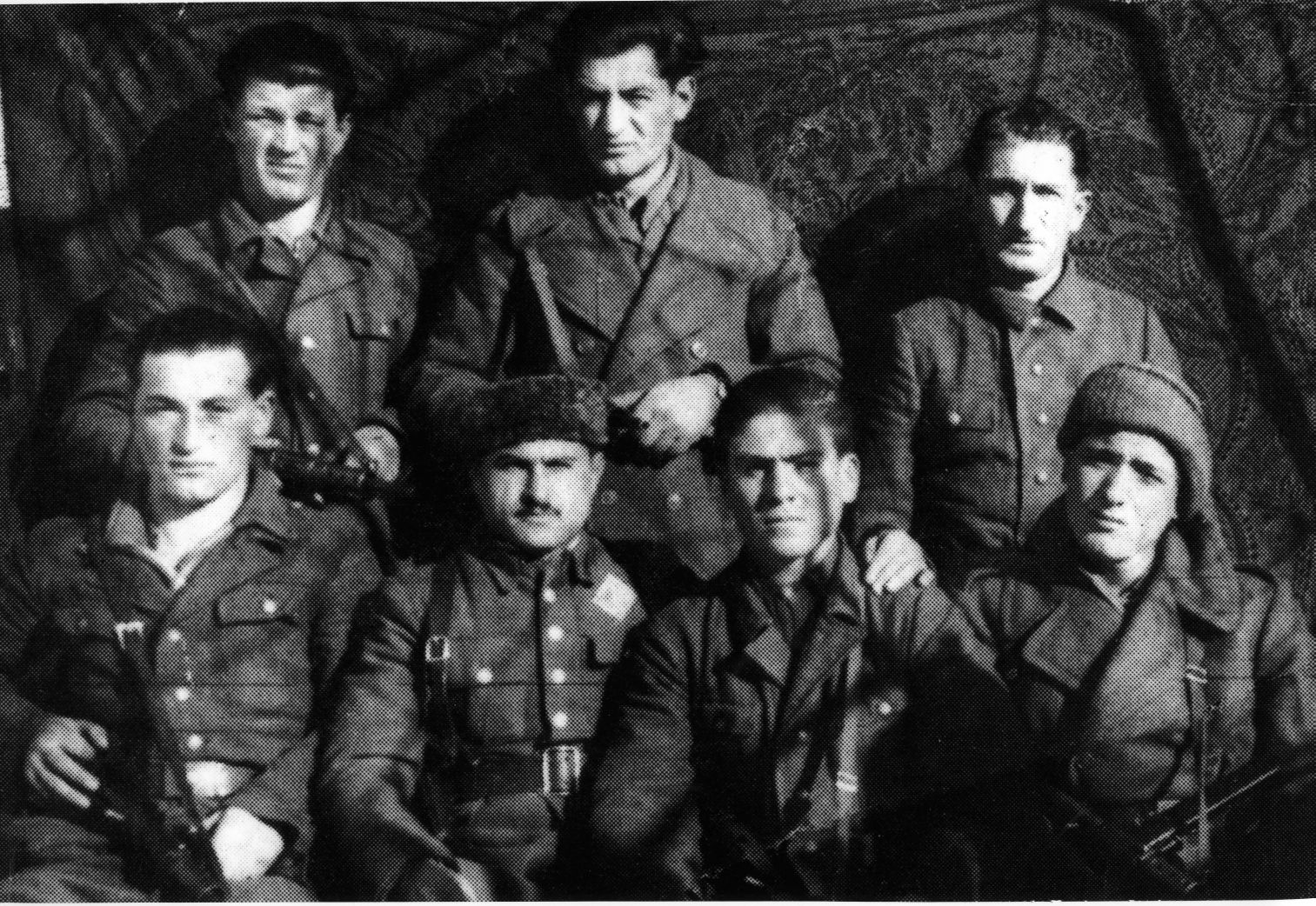La lunga estate partigiana non si risolse negli attacchi ai presìdi, negli assalti ai magazzini o nei sabotaggi ai ponti e alle vie di comunicazione; altri fenomeni contraddistinsero questa stagione di crescita del movimento resistenziale, che proprio grazie a questi finì per assumere quei caratteri di movimento di popolo che lo proiettarono ben al di là della dimensione militare.In questo senso la storia della 17a brigata Garibaldi “Felice Cima” è esemplificativa. Anzitutto per la costituzione, nel mese di luglio, di un distaccamento femminile intitolato ad “Anita Garibaldi”, formato in parte da donne della zona, che continuavano a risiedere nelle loro case, e in parte da donne già attive nella Resistenza ma ormai individuate e quindi costrette ad abbandonare i centri di pianura, che invece formarono un gruppo mobile, con sede prevalente a Favella.Le “garibaldine” svolsero più che altro servizi di sartoria, infermeria o staffetta, ma furono disponibili anche a partecipare attivamente ai combattimenti e vollero, nonostante le forti obiezioni dei loro compagni -uomini gelosi del mito maschile del guerriero e che quindi tendevano a ridimensionare il ruolo femminile-, essere considerate partigiane a tutti gli effetti. La nascita del loro gruppo fu anche indicativo di un momento di crescita e di ridefinizione del rapporto uomo-donna, che rappresentò il passaggio all’acquisizione di un ruolo da protagoniste anche nello spazio pubblico e alla conquista di una dimensione politica.
Anche la nascita dei giornali murali e i dibattiti dell’”ora politica” furono indicativi del bisogno di proiettarsi al di là della dimensione militare della lotta in corso. Già nel mese di luglio, il distaccamento “Faleschini”, allora alle miande Concessa, iniziò a pubblicare “Saetta Garibaldina”, un semplice foglio dattiloscritto, importante testimonianza del bisogno, nato sull’onda emotiva del rastrellamento del 2 luglio, di affermare la propria esistenza come pure di trovare un senso nelle vicende che si stavano vivendo. L’esperienza venne ripresa nell’autunno con ben altra maturità e prospettive, quando i giornali di brigata e di distaccamento diventarono uno strumento attraverso cui, oltre alla rivendicazione identitaria, il movimento partigiano iniziava a prefigurare il futuro postbellico. La cosiddetta ”ora politica”, poi, ossia l’appuntamento quasi quotidiano di “studio collettivo di storia e di politica”, fu un’altra tappa importante del processo di maturazione del movimento resistenziale, che testimonia l’esigenza sentita dai partigiani, giovani cresciuti in una scuola che si limitava a ripetere le parole d’ordine della retorica fascista, di trovare un’occasione per confrontarsi e per tentare almeno di elaborare una visione critica della realtà.