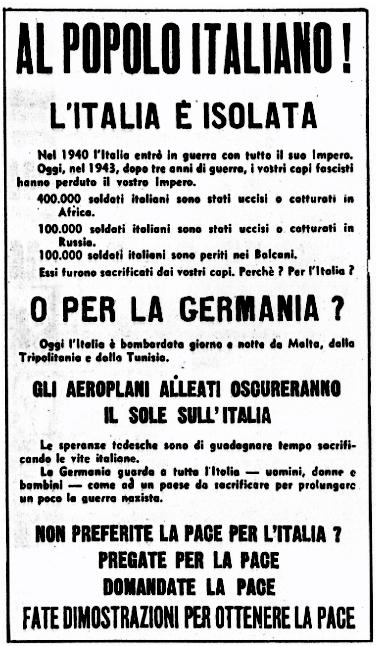La situazione politica italiana precipita dopo che, il 10 luglio, gli Alleati effettuano un massiccio sbarco di truppe in Sicilia. Mussolini, consapevole di quanto la guerra sia compromessa, incontra Hitler il 19 luglio, ma ne subisce passivamente l’incitamento a combattere fino all’ultimo. Il 25 luglio, però, è messo in minoranza dal Gran consiglio del fascismo, con un ordine del giorno che prevede l’eliminazione delle strutture totalitarie e il ripristino della legalità costituzionale.
Si tratta in sostanza di un colpo di Stato finalizzato a salvaguardare la continuità delle istituzioni, che vede alleati il re, i vertici dell’esercito ed una parte dello stesso apparato di potere fascista: Mussolini è arrestato e imprigionato a Campo Imperatore, in Abruzzo, mentre l’incarico di primo ministro è affidato al generale Pietro Badoglio, che pure ha condiviso tutte le scelte politiche e militari del regime. Non a caso, nulla di quanto ha caratterizzato il passato è messo in discussione: non l’alleanza con la Germania né la guerra né tanto meno la forma dittatoriale del potere, semplicemente trasferito ai militari.
La caduta del fascismo s’ambienta tutta “dentro il Palazzo” e, per capire la ragione di ciò, occorre tener conto della diseducazione di massa alla critica, che ha corrotto un’intera generazione. Del resto, il regime è stato una sorta di “malattia costituzionale” cui hanno concorso vari fattori: la giovane età dello Stato, ma anche la sua debolezza, dovuta al persistere delle identità regionali, all’influenza sociale della Chiesa ed alla mancata accettazione delle istanze di emancipazione avanzate dal proletariato industriale ed agricolo.
Negli ultimi giorni di luglio, in tutto il Paese si susseguono spontanee dimostrazioni di gioia, motivate dalla speranza che la guerra finisca presto, ma nei giorni seguenti esse tendono ad attenuarsi nelle aree rurali e rimangono vive solo nelle grandi città del Nord, in Emilia e in Toscana, dove assumono un deciso indirizzo politico, rivendicando l’epurazione dei fascisti, la liberazione dei prigionieri politici e la smilitarizzazione delle fabbriche.
Dopo che il generale Roatta ha proclamato lo stato d’assedio, l’esercito riesce a soffocare anche queste residue manifestazioni, con una repressione che provoca 83 morti tra Milano, Bari e Reggio Emilia, 308 feriti e 1.554 arresti.
Va comunque chiarito come tali proteste non abbiano mai assunto un carattere insurrezionale vero e proprio, testimoniando il permanere di un diffuso consenso nei confronti di chi guida lo Stato.Dopo il 25 luglio, il re e Badoglio assumono un atteggiamento ambiguo: ignorano la resa incondizionata chiesta dagli Alleati, abbandonano le truppe italiane tenendole all’oscuro di tutto, “decidono di non decidere” non escludendo un’ulteriore inversione di rotta politica. Quest’ambiguità dà modo ai tedeschi di attuare l’operazione Alarico: essi rafforzano la propria presenza militare nella penisola, ammassando truppe soprattutto nel Centro-Nord (circa 400.000 uomini) ed effettuando una vera e propria occupazione del territorio; iniziano ad incapsulare le forze armate italiane ovunque sia possibile, disarmandole e deportandone gli effettivi in Germania allo scopo di utilizzarli nel lavoro coatto; eseguono razzie d’armi e di beni
.